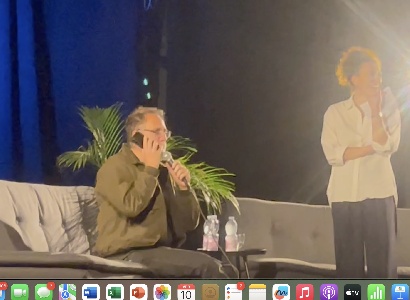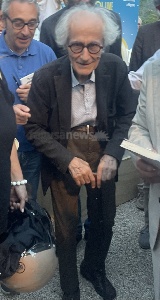Modica - L'itinerario dell'11 agosto, con appuntamento alle ore 21.00 sulla scalinata di San Giorgio riguarda le due Mater Ecclesiae di Modica, tra le architetture monumentali più importanti e significative del tardobarocco siciliano.
San Giorgio, una chiesa che è il simbolo della città, luogo religioso plurisecolare che si lega alla storia politica e sociale della contea. Vicina al CAstello dei Conti, vicina ai palazzi dell'aristocrazia che ha avuto ruoli amministrativi rilevanti nell'amministrazione comitale, dai Grimaldi, ai Lorefice, ai Tomasi Rosso, ai Polara.
Nella sua storia si possono individuare quattro momenti. Il primo è legato al grandioso polittico dell'abside, il più grande polittico ligneo siciliano, opera attribuita a Bernardino Niger e datata 1573. Un polittico che rimanda ai retabli spagnoli nel suo impianto architettonico, ma che nella sua iconografia e si colloca nell'ambito del classicismomanieristico di tradizione raffaellesca, mediato dalla cultura formale messinese degli anni centrali del Cinquecento. Vi si rappresentano i misteri gloriosi, i misteri gaudiosi e due santi cavalieri, San Giorgio e San Martino.
Il secondo momento ha una data precisa, il 1643, l'anno in cui si decise la ricostruzione con un nuovo progetto della chiesa su disegni di Frate Marcello da Palermo, un frate che abitava nel convento di Sant'Anna. Un grande progetto che sarà realizzato nei decenni successivi con un imipanto a cinque navate divise da colonne e da pilastri. Quella chiesa, appena finita, viene notevolemte danneggiata dal terremoto del 1693, e in questo terzo momento, che durerà, possiamo dire, l'intero secolo, in parte si restaurerà ,in parte si riprogetterà all'insegna delle nuove tendenze stilistiche settecentesche. Oltre agli altari interni, oltre ai cicli decorativi in stucco, l'impegno maggiore sarà quello di una nuova facciata che si deciderà di riprogettare ex novo mediante un concorso di idee del 1761. Vincerà quel concorso l'architetto netino Francesco Paolo Labisi, un architetto dotto la cui prevalente formazione è legata al gusto rococò, anche tramite le incisioni tedesche che circolavano nell'area iblea. Il Labisi doveva essere alquanto umbratile e litigioso se molto spesso avrà contenziosi nei vari cantieri. Ed un contenzioso l'avrà pure per la fabbrica di San Giorgio, di cui disponiamo le tesi dei contendenti, senza sapere l'esito. Quella facciata grandiosa, a cinque partiti, con il partito centrale svettante con le colonne che come canne d'organo salgono verso il cielo, vedrà la fine soltanto alla metà dell'Ottocento, novant'anni in tutto, che però non si notano, dato il risultato finale scenografico unitario e coerente.
Il quarto tempo è quello della scalinata, su progetto dello Iudica Cappellani, del 1875, una scalinata con funzione urbanistica di cerniera tra la città alta e la città bassa. Il risultato architettonico-urbanistico sarà tra i più sorprendenti dell'architettura italiana. Non si mancherà di menzionare alcune opere d'arte dell'interno dall'Assunta di Filippo Paladini del 1610, ad una scultura rinascimentale dei primi del Cinquecento, all'altare in argento del Settecento, ai cicli decorativi in stucco dei primi del Novecento del palazzolese Giuliano.
Scendendo nella parte bassa della città ci si imbatte nella chiesa dell'ex Collegio gesuitico, un'opera architettonica meno appariscente ma molto preziosa, essendo una delle prime opere dell'insorgente talento di Rosario Gagliard, progettata probabilemente intorno al 1720 e che sarà realizzata nell'arco di venti anni circa, con una facciata convessa in cui gli elementi strutturali conteranno di più rispetto agli elementi decorativi. Di spalle il Collegio gesuitico che aveva visto la luce originariamente nel 1630, sarà più volte trasformato per assumere la sua fisionomia definitiva negli anni settenta ottanta dell'Ottocento per ospitare il Liceo Classico e l'Istituto Tecnico.
L'altra Mater Ecclesia, che per secolo ha rivaleggiato con San Giorgio per questo titolo e per tutte le conseguenti prerogative lituergiche, è quella di San Pietro. Interi volumi nei due archivi parrocchiali sono pieni di liti e controversie di avvocati nei vari fori. Sicuramente fin dal Cinquecento il ruolo di San Pietro era in crescita nella storia sociale della città e lungo il Seicento sarà ampliata e arricchita di altari. Il terremoto del 1693 la demolisce in molte parti. Ma la volontà di ricostruirla e soprattutto l'urgenza fu dettata dalla necessità di non perdere prerogative. Sarà la prima chiesa monumentale dell'area iblea ad essere ricostruita negli anni immediatamente dopo il terremoto, per quanto passerà un secolo per una fisonomia in gran parte definitiva. La sua facciata è il risultato di due tempi. Il primo ordine sarà realizzato tra il 1696 e il 1710, all'insegna della continuità stilistica col manierismo del Seicento, opera di due valenti capimastri, Mario Spada e Rosario Boscarino, il secondo ordine sarà progettato e realizzato tra gli anni settanta e gli anni novanta del Settecento con un disengo rococò. Un risultato di assemblaggio tra due stili e due tempi che però riescono a saldarsi e a coniugarsi bene.
L'interno a tre navate, divese da monumentali colonne, acquisterà una fisionomia unitaria col ciclo decorativo già neoclassico nell'Ottocento, per quanto rimangono parecchi altari, alcuni del Seicento, altri del Settecento. Vi si conservano anche due sculture rinascimentali, la Madonna di Trapani e la Madonna del Soccorso. Nell'abside saranno collocate negli anni settanta tre belle sculture lignee del napoletano Pietro Padula, l'Immacolata, San Pietro e San Paolo.
Anche per San Pietro conta la scalinata antistante e contano le dodice statue degli apostoli che in modo ordinato e simmetrico vi saranno collocate.
Un itinerario tra i più suggestivi per chi vuole capire il val di Noto.
Paolo Nifosì