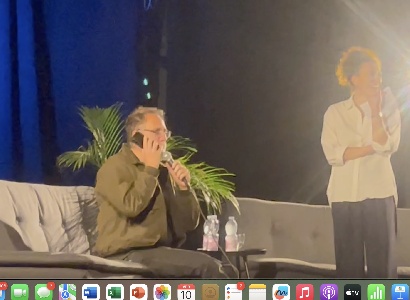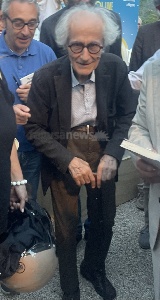Scicli - Che Scicli fosse la città dei pali era noto sin dal tempo dei romani.
Questa parola a diritto, infatti, è entrata subito nel suo dialetto utilizzata anche dalla gente più umile. Era contenuta un tempo in varie metafore, era tipica d’indovinelli di ogni tipo o, più specificamente, usata nella creazione di curiosi nomignoli e ‘ngiùrje (palìddu -da, ficupala, ecc...).
I “massa tufàni” (mezzani di professione) la usavano a proposito e a sproposito. Accanto a una ragazza “sana sana” (ingenua, cioè, quasi sprovveduta), era necessario collocare un buon “palu”, amavano ripetere, evocando l’immagine bucolica di una vite sorretta da un sostegno.
I vecchi e legnosi cladodi dei fichi d’India si chiamarono, non appena questa pianta attecchì in Sicilia, “palùna di ficumòra”.
Al femminile “pala” esprimeva un’idea di abbondanza: “peni cu la pala” o “sordi a palàti”.
La pala (quasi sempre di legno) era anche l’attrezzo usato per infornare il pane o per separare nell’aia il grano dalla pula con l’aiuto del vento. E c’era anche chi usava questa parola nell’accezione verbale con un significato negativo e ironico: “spalàri ’merda o càssaru”, intrufolarsi, cioè, nel pettegolezzo cittadino come una volta ci si arruolava per pulire con pale e scope Corso San Michele (cuore pulsante della vita politica e sociale) dalle deiezioni che inevitabilmente qualcuno, sottraendosi all’obbligo di conferire tali “rifiuti” alle latrine ubicate in periferia, buttava in strada durante la notte.
Ma qual è l’origine di questa parola?
Palo viene dal latino “palum”.
L’Oli Devoto registra questa definizione:
“Elemento strutturale cilindrico a sezione circolare o poligonale, con una dimensione preponderante sulle altre (lunghezza).”
L’importante dizionario enumera diversi tipi di palo o modi di dire con essi relazionati. Palo infisso, palo telegrafico, palo per fondazioni o trivellato. Il “palo”, per esempio, è una delle quattro aste che sostiene le corde agli angoli di un ring nella boxe; nel calcio è un montante della porta ma anche il tiro, in senso figurato, che colpisce tale montante.
“Palo” si dice di persona che vigila e protegge l’operato di un ladro. Si dice anche di persona la cui magrezza è impressionante e/o il cui andare è impettito e rigido: “Camìna cuòmu nu palu” ovvero “s’agghjuttìu u mànicu ra scupa” (mànicu qui sta per palo).
Nella Bibbia il palo sacro (anche se l’allusione fallica è evidente) non si riferiva, in effetti, all’organo maschile, che invece era rappresentato da una colonna, bensì alla vulva ed era, addirittura, il simbolo di una dea cananea della fertilità. Custodi del palo sacro nel tempio erano però prostituti.
Il supplizio del palo o impalamento era conosciuto già dal tempo degli egizi. I turchi comunque perfezionarono ad arte la tecnica e la diffusero.
Da sempre la malizia popolare ha usato “palu” e “vìrja” per indicare il fallo maschile.
A Scicli spesso la toponomastica ha impiegato tale termine per indicare strade o quartieri: “palu russu, palu jàncu” etc...
Qualcuno ha anche “impalato”, di recente, - e mi pare giusto!- con l’aiuto di un obiettivo fotografico San Matteo nel solco di un’affezionata tradizione cittadina che vuole la nostra città non solo ricca di pali come tanti obelischi diffusi nei punti più rappresentativi del centro storico barocco, ma sicuramente “AL PALO” cioè ferma o, nel peggiore dei casi, restia a qualsiasi sollecitazione a migliorarsi con intelligenza.
“Palo, palum, pali (rigorosamente con una “l”)...Qué paliza(1)!” Direbbe a questo punto un mio carissimo amico madrilegno.
(1) paliza = rottura di scatole, bastonata (tanto per restare in argomento!).